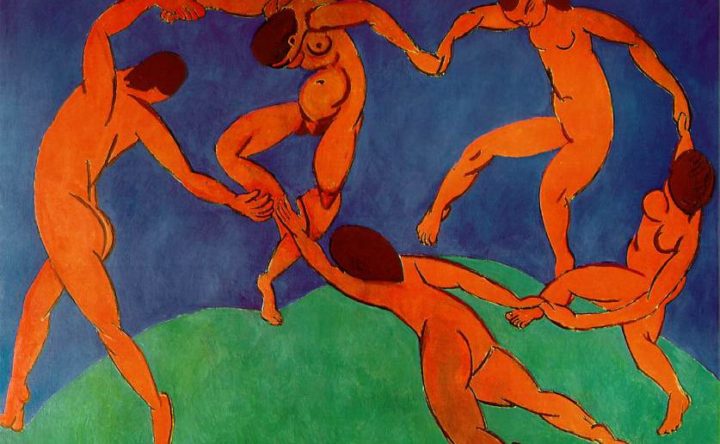Oggi purtroppo nella nostra società esistono ancora molti stereotipi di genere che segnano l’esistenza delle soggettività Lgbt e queer. Il senso comune fortemente omofobo e sessista sicuramente non aiuta ad affrontarli, né tantomeno le “crociate” indette dal neofondamentalismo di stampo cristiano e dall’estrema destra contro quello che viene definito “gender”, termine anglofono che viene usato per rendere l’argomento incomprensibile alla gente, rendendolo de facto un’etichetta patacca, un dispositivo retorico reazionario e un costrutto teorico e politico, inventato nel 1995, funzionale all’opposizione agli studi di genere e ai femminismi.
Non è giusto pensare però che queste oppressioni provengano solo dal neofondamentalismo o dall’estrema destra. Come ha scritto bene Federico Zappino nel libro “Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo”, anche il mercato affronta i temi sul genere in modo totalmente strumentale con il fine di ricreare nuovi brand, rigenerando se stesso.
Eh sì! L’oppressione proviene soprattutto dal neoliberismo progressista, come lo chiamerebbe Nancy Fraser, che mira ad aggirare quelle esclusioni fondate sul genere, usando strumenti che hanno il fine di includere le minoranze di genere e sessuali in tutti i campi del mercato e del capitalismo: nei processi di produzione e di valorizzazione (come il diversity management o il pinkwashing) o addirittura fornendo possibilità di soggettivazione per queste categorie mercificando istanze che un tempo erano conflittuali come i temi femministi ed Lgbtq (come il caso del pink-capitalism). Un’istituzionalizzazione dell’oppressione economica anche per queste categorie, quindi, promettendo una falsa emancipazione nel consumismo.
Le crociate neofondamentaliste si sono innescate in reazione al fatto che il capitalismo abbia pensato di prevedere delle “condizioni di inclusività” per queste soggettività, per esempio nelle pubblicità, nei programmi televisivi o addirittura nei dating show all’insegna del trash come Uomini e Donne di Maria De Filippi in cui è stato introdotto il “trono gay”. Mentre noi facciamo una critica politica a questa mercificazione, loro la conducono usandola strumentalmente non per criticare il capitalismo, ma per portare avanti crociate medievali fatte di mistificazioni contro l’aborto, i diritti Lgbtq, i diritti riproduttivi, il femminismo, l’educazione di genere e all’affettività nelle scuole cercando di portare indietro la lancetta dell’orologio al periodo pre-Sessantotto.
Per gli ultraconservatori, vedere in tv queste soggettività (per quanto stereotipate) in egual modo in cui vengono riprodotti i modelli stereotipati di “uomo” e di “donna”, risulta inaccettabile. Loro lo vivono come un vero e proprio scandalo che tocca la loro confort-zone, dando adito a ondate di moralismo in difesa di tutte le più becere assurdità sessiste di matrice provinciale.
Dall’altro lato, il neoliberismo manipola i discorsi sul genere per assimilarli producendo delle distorte idee di trasgressione e di libertà, rendendo sia la trasgressione sia la libertà dei valori mercificabili a proprio uso e consumo. Il risultato che si ha è un po’ come quello che produsse l’introduzione della parola “felicità” nella Costituzione americana a fine 1700: una grande presa in giro nonché tra le più grandi fake distopiche della storia.
Ho riflettuto a lungo su questo tema, soprattutto dopo che ad ottobre è salita alla ribalta la storia di Mark Bryan, un ingegnere meccanico di origini statunitensi che da diversi anni vive in Germania insieme a sua moglie e a sua figlia. Le sue giornate sono esattamente quelle del classico padre di famiglia che si divide tra casa, lavoro e passioni, con l’unica differenza che lo fa “sfidando gli stereotipi di genere perché quasi sempre indossa tacchi e gonne”.
Partiamo dalla questione di genere. Mark ha tutto il diritto di vestirsi così, anzi esprime il suo essere se stesso, la sua identità di genere, il suo percepirsi uomo contro i modelli culturalmente costituiti.
Nessuno ha il diritto di impedirgli di vestirsi in quel modo e lui ha tutto il diritto di difendere il suo genere. D’altronde esistono ancora un sacco di stereotipi sull’espressione di genere e le pratiche drag sono l’esempio di come il genere si può performare, fare e disfare mettendo in ginocchio quella che fino ad oggi è stata definita “normalità”. Certo è che un conto è sentirsi liberi di indossare quello che più piace senza sentirsi giudicati; un conto è diventare un baluardo dell’abbigliamento, mercificabile e privatizzabile, che fonda il proprio marketing su slogan che un tempo erano rivendicazioni, come per esempio: “sono ancora moltissime le persone che credono che gli indumenti abbiano un genere”. Un’espressione che, oggi, sentiamo rimbombare in lunghissimi articoli di fashion-blogger che danno consigli sulla moda all’ultimo grido.
Da questo punto di vista non vedo cosa ci sia di trasgressivo, di urtante, di politicamente costruttivo nell’abbigliamento di Bryan. Lui “trasgredisce” la norma eterosessuale e i canoni che la concepiscono, ma non la norma del marketing che ha prodotto i suoi vestiti, come esattamente tutte le altre mode. Quel vestire in “maniera non conforme” in realtà è aderire in maniera conforme al glamour, al trash, a quel mondo che piace tanto a Vanity Fair: la nuova moda, che non è altro che il riproporre in maniera innovativa la moda degli “anni del riflusso”, ovvero l’accelerazione del nulla e il bug del consumismo.
A settembre 2019 c’è stata la ristampa del libro “No Logo” di Naomi Klein, la quale nella prefazione racconta come negli ultimi vent’anni il brand delle grandi multinazionali sia fortemente cambiato da quando aveva scritto il suo bestseller. L’operazione di rebranding delle multinazionali è passata dal focalizzarsi sui marchi al puntare tutto sulle idee: Starbucks da marchio di caffetteria è diventato l’idea di comunità; e Nike da marchio di scarpe da ginnastica è diventata l’idea di trascendenza attraverso lo sport. Non solo, come afferma Klein, lo stesso titolo di “No Logo” è diventato un brand a tal punto che alcune multinazionali hanno iniziato a produrre “prodotti senza marchio”. Il culmine, quindi, di quella strategia di rebranding scoppiata negli anni Novanta quando gli esperti di marketing si sono stancati dei limiti tradizionali della pubblicità, aggiungendo al valore nominale del marchio tutto un mondo fatto di mozione degli affetti e immagini sociologicamente studiate per “fottere” la gente. Che dire quindi della moda genderless, che magicamente negli ultimi anni è iniziata a piacere a tutti i più grandi magnati delle case d’abbigliamento: da Prada ad Armani, da Benetton a D&G. Anche loro hanno capito che quel “vestire in maniera non conforme” potesse in realtà diventare un modo per aderire conformemente al glamour, oltre che essere un buon compromesso per fare soldi attraverso un nuovo brand alla moda.
Tronando a Bryan, siamo realisti: se questa è libertà, la prigione è meglio perché meno ipocrita. Un ingegnere meccanico alle dipendenze non va agli incontri di lavoro vestito in quel modo, almeno che non sia proprio “l’azienda madre” a permetterglielo, usandolo quindi come un marchio. Non dimentichiamoci che le sue foto sono state prese da moltissime riviste di moda.
Ci sono tanti modi per trasgredire la norma eterosessuale e tantissime pratiche drag, ma se non si esce dal marketing che lo permette che trasgressione è?
Se si trasgrediscono delle norme, ma si aderiscono a delle altre non può esserci trasgressione, ne tantomeno sovversione. Solitamente chi trasgredisce non ama le etichette, non compra un vestito di centinaia di euro. La trasgressione non ha schemi, è anticonformista, non appartiene a nessun sistema. Non è concessa e non ha padroni. La trasgressione è veramente libera e sempre dissidente.
Questo modo di vendere la “libertà” e la “trasgressione” da parte del capitalismo somiglia tanto a quei messianesimi religiosi che hanno lo scopo di promettere la felicità a tutti i costi: materialmente illusoria, ma nominalmente molto attraente.
Il neoliberismo oggi è capace di produrre processi di inclusione delle minoranze sessuali e di genere non attraverso una sovversione delle gerarchie ma attraverso emancipazioni illusorie che portano soltanto ad una naturalizzazione e rigenerazione delle gerarchie stesse. Oggi come oggi, con un capitalismo neoliberista imperante che cerca di inglobare qualsiasi aspetto del reale, bisogna pensare necessariamente a forme decolonizzate di antirazzismo, di femminismo e di lotte queer altrimenti possono diventare solo grandi mode. Come ha ben detto la sociologa eco-femminista Laura Corradi1, riprendendo Violeta Vaida, c’è bisogno di un’ermeneutica decolonizzante2, altrimenti le nostre posizioni, i nostri temi e i nostri discorsi saranno sempre assimilabili, non indipendenti, al discorso dominante capitalista ed eteronormato. Fino ad oggi il postcolonialismo ci ha permesso di spostare lo sguardo sul mondo, ora però bisogna provare a cambiare il mondo.
2# Un paradigma sovversivo di destrutturazione del linguaggio, di concetti e di parole